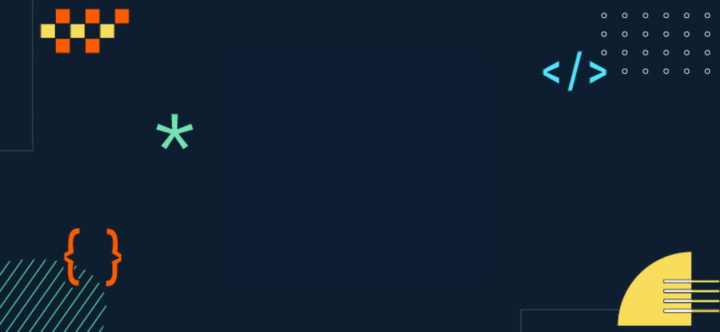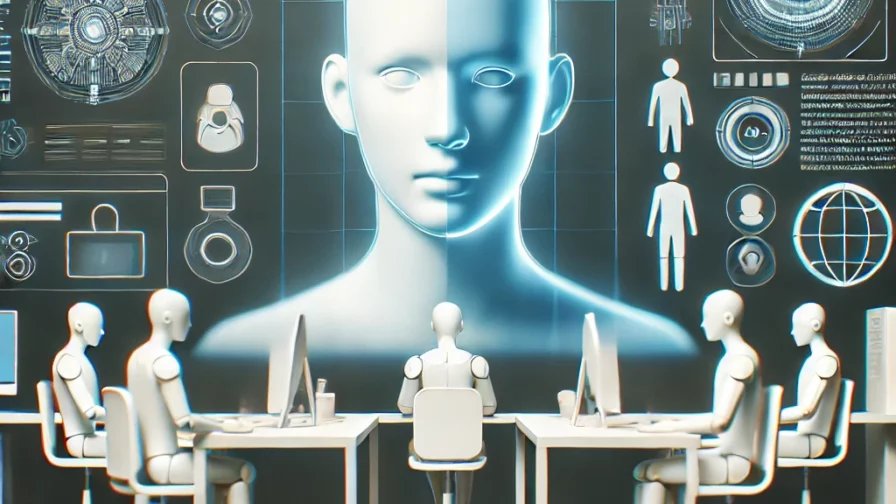
Come le aziende reali attraversano (davvero) le fasi dell’AI adoption
Quando si parla di AI adoption in azienda, il rischio più grande è raccontarla come un percorso lineare, pulito, quasi inevitabile.
La realtà è molto diversa. Le aziende non “seguono un framework”, lo attraversano inciampando, tornando indietro, bloccandosi e ripartendo. Il valore di un modello non sta nel presentarlo come una ricetta, ma nel riconoscere i pattern che emergono quando si osservano casi reali, anche molto diversi tra loro e adeguarsi di conseguenza
Se guardiamo con attenzione aziende come Klarna, Morgan Stanley o GitHub, il percorso non parte mai da una “AI strategy” presentata su delle slide. Dietro c’è quasi sempre da un bisogno concreto, spesso operativo, che viene razionalizzato solo dopo a volte anche con qualche aggiustamento. Il framework Tool → Use case → Workflow → Governance → Scale non è quindi una mappa teorica, ma una fotografia ricorrente di come l’adozione si realizza nella pratica.
All’inizio c’è sempre il tool. È inevitabile. Qualcuno introduce l’AI perché è facile, perché il mercato la spinge, perché i competitor ne parlano o perché i dipendenti la stanno già usando in modo non ufficiale. In questa fase il valore è reale ma flebile e fragile. Le persone sperimentano, scoprono che possono scrivere più velocemente, rispondere meglio, produrre output accettabili in meno tempo. È una fase esplorativa, quasi anarchica, che però ha un merito enorme: rende l’AI concreta. Finché l’AI rimane un concetto strategico, non crea alcun cambiamento. Diventa interessante solo quando qualcuno la usa davvero, anche in modo imperfetto.

Il problema è che il tool, da solo, non crea adozione. Anzi, spesso crea l’illusione che l’adozione sia già avvenuta. Molte aziende si fermano qui. Hanno accessi attivi, licenze pagate, qualche storia di successo individuale e una percezione vaga di miglioramento. Ma se si guarda ai processi, nulla è cambiato. L’AI è un acceleratore personale, non un elemento strutturale.
La svolta avviene quando emergono i primi use case veri. Non dieci, non cinquanta, ma uno o due casi ripetibili, riconoscibili, abbastanza importanti da giustificare attenzione. È qui che il discorso cambia. Klarna è un esempio chiarissimo. L’azienda non si è limitata a dire “usiamo l’AI nel customer service”. Ha scelto di inserire un assistente AI direttamente in uno dei processi più critici e costosi, la gestione delle richieste dei clienti. Questo passaggio è fondamentale, perché sposta l’AI da “strumento di supporto” a “parte del lavoro”.
In questa fase l’AI smette di essere un esperimento individuale e diventa un oggetto organizzativo. Inizia a sollevare domande scomode. Funziona sempre o solo a volte? Quando sbaglia, chi se ne accorge? Chi è responsabile dell’output? Qual è il livello di qualità accettabile? Queste domande non esistono nella fase del tool, ma diventano inevitabili quando l’AI tocca un processo reale. Ed è proprio questo il segnale che l’adozione sta iniziando.
Il passaggio successivo è quello che molte aziende sottovalutano: l’integrazione nel workflow. Qui l’AI smette definitivamente di essere “un assistente esterno” e diventa parte del flusso quotidiano. Non è più qualcosa che usi quando ti ricordi, ma qualcosa che entra in modo naturale tra un passaggio e l’altro del lavoro. È in questa fase che Morgan Stanley offre uno spunto molto interessante. Gli strumenti di AI introdotti non sono chatbot generici, ma componenti che si inseriscono in momenti specifici del lavoro dei consulenti, come il debriefing dopo una call o l’accesso a grandi quantità di ricerca interna. L’AI non sostituisce il professionista, ma cambia il modo in cui lavora, riducendo il tempo speso su attività ripetitive e aumentando quello dedicato a decisioni e relazione.
Quando l’AI entra nel workflow, accade una cosa cruciale: il lavoro cambia. Le persone smettono di partire dal foglio bianco e iniziano a partire da una bozza. Passano meno tempo a produrre e più tempo a verificare( o almeno dovrebbero). Questo spostamento è spesso sottovalutato, ma ha implicazioni enormi. Cambia le competenze richieste, cambia il valore della seniority, cambia il modo in cui si forma chi entra in azienda. Ed è qui che molte organizzazioni iniziano a sentire resistenze culturali. Non perché l’AI non funzioni, ma perché mette in crisi identità professionali consolidate.
È a questo punto che emerge in modo inevitabile il tema della governance. Finché l’AI è un tool usato individualmente, la governance sembra un problema teorico. Quando entra nei processi, diventa una necessità concreta. Morgan Stanley, ad esempio, può permettersi strumenti di AI solo perché sono costruiti su fonti controllate, con perimetri chiari e responsabilità definite. In contesti regolati, l’AI non è adottabile senza governance. Ma questo vale anche in aziende meno vincolate: senza regole minime, l’adozione non scala, perché il rischio cresce più velocemente del valore.
Ed è importante chiarire un punto: la governance non arriva per frenare l’AI, ma per renderla utilizzabile. Molte aziende commettono l’errore di introdurre regole troppo presto, quando ancora non hanno capito dove sta il valore. Altre, all’opposto, ignorano la governance finché non succede un incidente. Nei casi di adozione più maturi, la governance emerge come risposta a un problema reale, non come esercizio teorico. È una differenza sottile ma decisiva.
Solo dopo questi passaggi arriva la scala. La scala non è semplicemente “più utenti” o “più licenze”. È la capacità di rendere l’uso dell’AI consistente tra team diversi, ruoli diversi, contesti diversi. GitHub Copilot è un esempio interessante proprio perché mostra quanto questo passaggio sia delicato. A livello individuale, Copilot aumenta la velocità di scrittura del codice. A livello aziendale, però, questo beneficio diventa reale solo se accompagnato da standard, test, review e formazione. Altrimenti l’AI accelera anche la produzione di debito tecnico.
Scalare significa rendere l’AI indipendente dai singoli. Non deve funzionare solo perché “quel team è bravo”, ma perché il sistema è progettato per reggere. Questo richiede metriche, feedback loop, ownership chiare e un investimento continuo. Ed è qui che molte aziende si bloccano. Non perché non vedano il valore, ma perché scalare costa fatica, richiede coordinamento e obbliga a prendere decisioni politiche interne.
Guardando questi casi insieme, emerge un messaggio molto chiaro. L’AI adoption non è un progetto con un inizio e una fine. È un percorso di maturazione organizzativa. Ogni fase ha un senso solo se prepara la successiva. Saltarne una crea squilibri. Restare bloccati troppo a lungo in una fase crea frustrazione.
Il motivo per cui il framework Tool → Use case → Workflow → Governance → Scale funziona come chiave di lettura è che non idealizza il percorso. Non dice come dovrebbe essere l’adozione, ma come tende ad accadere quando l’AI viene portata nel mondo reale. Ed è anche per questo che è utile a chi scrive di AI in modo serio. Permette di smontare la retorica dell’ “AI-first company” e di riportare il discorso su ciò che conta davvero: processi, persone, responsabilità.
Alla fine, la domanda non è se un’azienda usa l’AI. La domanda è a che punto del percorso si trova. Perché usare l’AI come tool è facile. Integrarla nei workflow è difficile. Governarla è complesso. Scalarla è una sfida strategica. Ed è proprio in queste transizioni che si gioca il vero vantaggio competitivo.