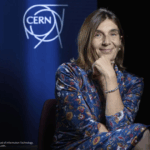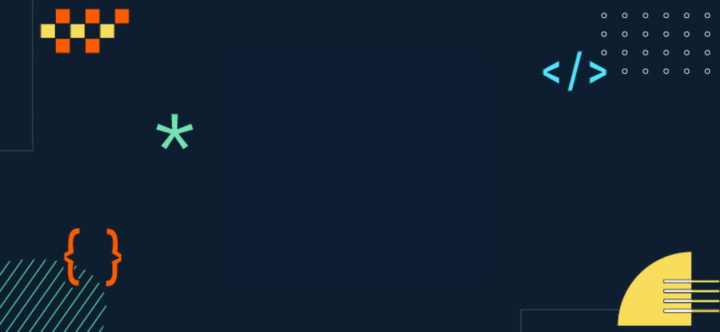Avere un’idea è probabilmente il passo più facile nella catena del valore di un’azienda.
Ho un’idea brillante, nella mia testa rivoluzionaria: inizio col realizzare un POC o creo un pitch fatto bene e vado a bussare alle porte degli investitori.
Nella mente di uno “startupper“, questo primo passo, sublimato da un fundraising, è qualcosa di fondamentale: per molti rappresenta una sensazione più forte rispetto a quella di dichiarare il proprio amore alla ragazza che si frequenta da una vita.
Questo passo crea una dose di adrenalina e autostima tale che spesso il primo pensiero che si fa è:
"famo er botto"Code language: JSON / JSON with Comments (json)Questa frase rimbalza nella testa di chiunque quando si guarda il conto corrente a 6 cifre dell’azienda e si iniziano ad annusare i soldi ricevuti da generosi investitori.
Col tempo, questa “droga” aziendale diventa una dipendenza: è mille volte più facile trovare un round di finanziamento che nuovi clienti.
Per crescere devi incontrare centinaia di possibili clienti e convincerli che il tuo prodotto è qualcosa di fantastico, mentre per convincere un investitore devi bussare alla porta di molte meno persone e la leva è diversa: non vendi qualcosa di tangibile, ma solo l’idea e il fatto che “cambierà il mondo” – che poi magari lo cambierà davvero, ma non è detto.
A volte bastano un founder istrionico, un pitch ben fatto e una narrazione avvincente per convincere un investitore a scommettere su di te.
Ma proviamo ad analizzare cosa succede, quali sono i pro e i contro e perché questo è un meccanismo diabolico che rischia di generare mostri a tre teste, privi di qualsiasi attrattiva commerciale.
Il paradosso della prosperità apparente
Un fenomeno che si sta allargando a macchia d’olio è la cosiddetta “sindrome da cash-rich, revenue-poor” (la frase non è mia, ma rende bene l’idea): abbondanza di capitale non sostenuta da adeguati ricavi. Sono ricco perché un investitore ha creduto in me, ma i miei clienti ancora non ci credono abbastanza da rendere virtuoso il mio percorso.
Il finanziamento iniziale e i vari round di crescita dell’azienda, che per loro natura dovrebbero essere un mezzo finanziario strategico per raggiungere specifici obiettivi di business, stanno diventando, in alcuni contesti, l’unico fine di sostentamento:
L'azienda "pinco pallo" ha avuto l'ennesimo round di finanziamentoCode language: JavaScript (javascript)A seguito di questo annuncio, una nuvola di giornalisti, blogger e startupper festeggia stappando champagne e brindando al successo.
In realtà dovrebbero festeggiare il fatto che l’azienda ha raggiunto un obiettivo di business come l’aumento dei clienti, il miglioramento della redditività, la crescita dei ricavi o l’espansione in nuovi mercati.
Festeggiare un finanziamento è come essere felici perché la nonna ti ha aumentato la paghetta mensile, ma tu ti guardi allo specchio e sei il disoccupato di sempre, che spende i soldi per uscire con gli amici, pagare le sigarette e comprarsi la macchina, ma non per cercarsi un lavoro.

Il contesto macroeconomico del capitale abbondante
Negli ultimi dieci anni, il mercato del venture capital ha vissuto un afflusso di liquidità senza precedenti, con ripercussioni significative anche a livello europeo e italiano.
Dati recenti mostrano una crescita esponenziale: in Italia, gli investimenti in venture capital sono aumentati in modo considerevole tra il 2013 e il 2023, raggiungendo un totale di oltre 8 miliardi di euro, come si può leggere in molti report. Ne riporto uno a titolo di esempio: p101.
L’ammontare medio per round è cresciuto molto, dipingendo il quadro di un mercato inondato di capitale, dove i fondi non solo hanno più denaro da distribuire, ma lo fanno anche in blocchi di maggiori dimensioni. Il risultato è un ecosistema dove la disponibilità di fondi è diventata la norma: è normale ricevere molto.
L’investitore nervoso nel mercato competitivo
Dato che è complicato capire quale sia effettivamente la prossima killer application, i fondi di venture capital si sono affrontati in un contesto di forte competizione per assicurarsi le startup che “sembravano” la prossima grande idea.
Questa competizione ha dato vita a un fenomeno noto come “Fear Of Missing Out” (FOMO), ovvero la paura di perdere un’opportunità di investimento: cosa faccio? Mi faccio scappare questa startup che, se andasse bene, mi potrebbe coprire di denaro? Dai, molliamoci un centone.
Non si tratta solo di un aspetto emotivo, ma di un fattore che può alterare le decisioni operative. Gli investitori, spinti dalla necessità di agire rapidamente, saltano le fasi cruciali dell’analisi finanziaria e di mercato, basando le proprie decisioni su “hype” e intuizioni, piuttosto che su dati oggettivi.
Questo mi fa ricordare una startup che ho seguito qualche tempo fa. Eravamo in pieno hype blockchain e la startup in questione aveva un’idea interessante, ma non un prodotto.
Arrivando come analista tecnico di soluzioni software, il mio giudizio è stato sostanzialmente negativo: sottolineavo il fatto che non c’era nulla di valutabile, quindi l’unica valutazione poteva essere fatta sulle persone, non sulla parte tecnica, completamente assente.
Dopo qualche anno da quell’evento, il risultato è stato che la startup ha ricevuto dei finanziamenti, ma nella sostanza non ha mai prodotto nulla di concreto e quello che sopravvive ancora sono dei canali Telegram di clienti ormai rassegnati ad aver perso i propri soldi.
Questo è un caso di processo disfunzionale: soldi arrivati nelle mani di persone con un’idea, che tali sono rimaste, in assenza di un prodotto con un reale mercato.
Cosa muove questa dinamica?
Gli investitori sono spesso spinti da una narrazione accattivante o da una personalità carismatica piuttosto che da un solido modello di business o da metriche di crescita tangibili.
Ricordo un altro incontro avuto circa una decina di anni fa con una startup che voleva lanciare un nuovo motore di ricerca, che superasse la logica di Google e potesse dare risultati più precisi e puntuali, quello che adesso sta diventando realtà con strumenti come Perplexity o con la AI mode di Google.
L’idea era innovativa, si basava su prodotti allora consolidati: se non ricordo male utilizzava Lucene come motore di ricerca. Tutto era trainato da una figura brillante, carismatica, in grado di affascinare chiunque. Aveva una sola pecca: non era una persona tecnica e, nel momento in cui spiegava le mirabolanti innovazioni della sua soluzione, la narrazione era carente, ma finché ne rimaneva fuori era assolutamente affascinante.
Per questo motivo, nonostante le mie perplessità, la startup riuscì a raccogliere un ingente finanziamento. Il prodotto vide la luce, ma alla fine non riuscì a decollare e finì tutto in tribunale.
La disconnessione tra fundraising e business
Il fundraising, per come è percepito, diventa un gioco di psicologia e persuasione:
Facciamo un pitch che spacca, raccontiamo una storia che faccia sognare e vedrai che i soldi arrivanoMentre la costruzione di un’azienda che produce reddito è un’attività completamente diversa, di puro pragmatismo, si potrebbe dire.
La narrazione di un sogno futuro è più facile da vendere rispetto a un prodotto che deve risolvere un problema attuale, che i tuoi clienti hanno e che sono disposti a pagare: non dobbiamo inventare un problema e poi risolverlo, ma dobbiamo risolvere un problema esistente.
Il venture capital accetta l’alto rischio, si fa affascinare dai sogni e dalla possibilità di rendimenti eccezionali.
Questa strategia, chiamata anche “power-law distribution”, presuppone che la maggior parte delle scommesse di un fondo fallirà o restituirà un capitale modesto, mentre il successo verrà garantito da un numero ristretto di aziende, quelle poche, e a volte anche fortunate, startup che riescono a generare un ritorno molto superiore e, da sole, ripagano decine di errori di valutazione: anche di fronte a molti fallimenti, una sola startup potrebbe rendere tutto il fondo profittevole e, dato che il futuro non è prevedibile, investiamo sulle idee che ci sembrano le migliori, senza remore.
Pur essendo una strategia con un fondo di razionalità dal punto di vista del fondo, questo approccio crea come priorità la ricerca affannosa di un possibile “unicorno”.
Si preferisce investire in una startup “visionaria”, ma con zero ricavi, piuttosto che in un’azienda con una crescita lenta ma costante: la lentezza non ripaga, ripaga l’idea vincente che si sviluppa in poco tempo.
Per questo, se l’azienda supera i 5 anni di vita senza aver raggiunto un fatturato significativo, è probabile che venga abbandonata dagli investitori, anche in presenza di buoni margini e di una crescita costante.
L’ossessione per il fundraising e la perdita di focus sul cliente
Il rischio, tangibile e certo, è che le aziende perdano di vista il cliente o, meglio, che non diventi più il focus maggiore, avviluppandosi in crescite di prodotto non sostenibili con i ricavi, ma solo con i round di finanziamento ottenuti, che generano prodotti che, analisi di mercato alla mano, non vuole nessuno: ma l’azienda, con le casse piene, non riesce a realizzarlo perché ormai ha perso l’obiettivo aziendale e non è più in grado di focalizzarsi.
Questo mi fa ricordare la mia prima startup, o meglio azienda, dato che allora non si parlava ancora di startup.
Si trattava di un motore di ricerca verticale per offerte di lavoro.
Ai tempi il nostro “finanziatore” era Adsense: facevamo il 90% di fatturato con un unico mandatario e il nostro obiettivo era solo quello di accrescere il numero di visitatori, aumentando i nostri dati e di riflesso i nostri ricavi. Ma ci stavamo concentrando solo su questo.
Non avevamo capito che occorreva differenziare, rendere le entrate multiple, passare più tempo sulla parte commerciale.
Questa convinzione ci aveva fatto perdere di vista il cliente e, soprattutto, ci ha chiuso gli occhi e le orecchie quando un investitore vero aveva deciso di mettere sul piatto dei soldi per farci crescere commercialmente.
L’effetto fu che chi voleva finanziare noi andò a finanziare un altro aggregatore, che col tempo divenne leader di mercato, mentre noi scomparimmo nel momento in cui il nostro unico finanziatore, Adsense, decise di chiudere, lentamente ma inesorabilmente, il rubinetto.
Attenzione al burn rate e alla gestione finanziaria
Il “burn rate”, ovvero la velocità con cui una startup consuma il proprio capitale, è una delle metriche più cruciali per valutare la sostenibilità di un’azienda non ancora profittevole.
Viene calcolato considerando sia le spese totali che i ricavi e fornisce un’indicazione del tempo di autonomia finanziaria prima di esaurire le risorse.
Si potrebbe pensare che il finanziamento in eccesso sia in grado di estendere la vita di una startup, quando invece potrebbe agire come un catalizzatore negativo che accelera il burn rate.
Avere ingenti somme in banca può indurre a spese superflue che erodono rapidamente il capitale.
Questo include l’assunzione di personale prima che sia necessario, la locazione di uffici lussuosi e l’investimento in marketing non mirato.
Ripensando alla mia esperienza, sicuramente sono andato incontro ad almeno uno di questi errori.
Chiaramente le spese aumentano il burn rate, mettendo la startup nella condizione di “correre sul posto”. Gli investitori esperti vedono un burn rate elevato come un “red flag” se non è giustificato da un’evidente e proporzionale crescita dei ricavi.
Un’ampia disponibilità di capitale può generare anche la pericolosa “illusione del tempo”, portando a credere di avere un’autonomia illimitata per raggiungere la redditività: no ragazzi, il tempo non è infinito e se non crescete fate prima a chiudere e a pensare ad altro.
Come già scritto in un altro articolo, esperti come Enrico Pandian ci ricordano la strategia delle 2 settimane:
"Se non riesci a validare la tua idea in 2 settimane, è probabile che tu stia costruendo un castello di sabbia".Code language: JavaScript (javascript)Le casse piene estendono in modo abnorme questa percezione di tempo, ma il concetto di fondo rimane uguale: il tempo per validare un’idea non è infinito e più lo si allunga, più si rischia di costruire qualcosa che nessuno vuole.

La caduta dei giganti
Vediamo alcuni casi eclatanti di sovracapitalizzazione che hanno portato al fallimento di startup un tempo considerate “unicorni”.
- Theranos: La fondatrice Elizabeth Holmes ha raccolto oltre 900 milioni di dollari in sei anni senza un prodotto funzionante. L’intera azienda era una frode, costruita non su una tecnologia validata, ma su una narrazione seducente di rivoluzione medica e sul carisma della fondatrice. Il crollo di Theranos dimostra come gli investitori possano essere vulnerabili di fronte a una “storia” irresistibile.
- Juicero: Questo caso è l’archetipo della mancanza di “product-market fit”. La startup ha raccolto 120 milioni di dollari per un estrattore di succhi da 700 dollari, vincolato all’acquisto di costosi sacchetti preconfezionati. Un’idea che risolveva un problema banale e inesistente è stata spinta al fallimento da un eccesso di capitale che ha incoraggiato un business model irrazionale, smontato da uno youtuber in grado di spremere i loro sacchetti con le mani.
Chi sarà il prossimo?
Non è facile dirlo, molte aziende hanno dei modelli di business difficili da sostenere. Pensiamo ad esempio a Klarna, un modello che si basa sul “buy now, pay later”, ma i clienti stessi di Klarna sono entrati in un vortice di micro prestiti non pagati che ha aumentato l’esposizione finanziaria dell’azienda, mettendo in dubbio la sua sostenibilità a lungo termine. Solo il tempo dirà se Klarna, grazie al proprio capitale, riuscirà a ristrutturare il proprio modello per affrontare queste sfide o rimarrà intrappolata in questo ciclo poco virtuoso.
Questi casi dimostrano che il capitale, se non gestito con disciplina e se non supportato da un solido modello di business, può diventare una vera e propria maledizione che accelera il fallimento anziché garantire il successo.
Spesso il fallimento è una lezione fondamentale
Il fallimento è doloroso, sia finanziariamente che mentalmente, ma a volte diventa fondamentale per crescere.
Spesso si racconta di Dyson e dei suoi 5126 fallimenti che hanno poi portato al suo primo prodotto di successo: l’aspirapolvere senza sacco.
Chi ha vissuto sulla propria pelle un fallimento, la cosa migliore che può fare è analizzare e imparare dai propri errori.
Pensiamoci: è più educativo un fallimento che un successo. Il fallimento me lo ricordo e fa sì che al tentativo successivo alcune cose non siano più sottovalutate, mentre il successo anestetizza tutto e ci fa credere che il nostro operato sia perfetto.
Ma i venture capital
Forse qualcosa si sta muovendo anche su questo aspetto: dopo anni di eccessi, sopravvalutazioni e soldi sparsi in mille direzioni, si sta assistendo a un cambiamento. Non alla nascita di nuove aziende, ma alla ricerca di aziende con le casse piene ma pochi ordini, nella speranza che, ricalibrando prodotti e mercato, possano “svegliarsi” dal loro torpore e innescare quel virtuoso sistema di crescita che gli investitori si aspettano.
Sì, ma le aziende?
Il problema però potrebbe sempre essere l’azienda che, a causa delle casse piene e della perdita di focus, non riesce a capire quanto sarebbe utile una nuova guida in grado di cambiare la situazione che, lentamente ma inesorabilmente, le sta conducendo al fallimento.
Conclusioni
Guardiamo quindi con occhio diverso le casse aziendali, chiediamoci sempre: servono davvero tutti questi soldi? Li stiamo spendendo bene? Stiamo crescendo come clienti e fatturato? Se alcune o tutte queste risposte sono negative, forse è il caso di fermarsi e riflettere e investire veramente sulla crescita, magari non di prodotto, ma sicuramente commerciale e di marketing mirato.